Palazzo Sertoli, Sondrio - Iginio Balderi - 1992
Palazzo Sertoli, Sondrio - Iginio Balderi, testo scritto da Luciano Caramel, 1992
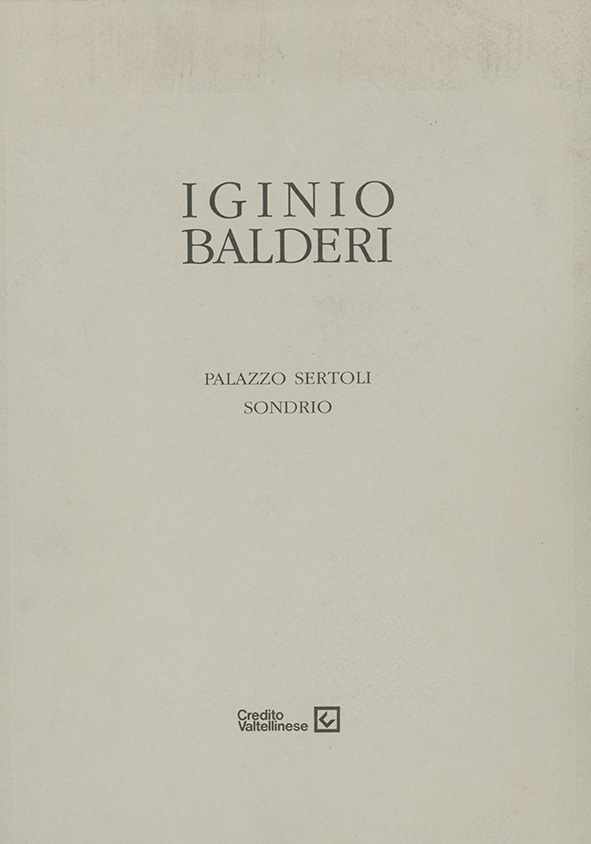
Quello di Iginio Balderi, classe 1934, da trent'anni sulla breccia, scultore, nome è un nome “che gira”. Certo più noto fuori dei nostri confini, dove ha ottenuto un'attenzione continua, in Italia è poco considerato, nel senso proprio etimologico, latino, del termine. Non è stato infatti guardato e studiato, complice, va riconosciuto, il carattere medesimo dell'artista, d'altronde consono alle sue posizioni di poetica, alle sue scelte problematiche di linguaggio.
Resta peraltro il fatto che quattro quinti delle sue mostre personali, dagli anni 70 almeno, sono state ospitate in gallerie straniere, in Germania, in Svizzera, in Belgio, in Olanda soprattutto, e in altri paesi del nord, dove le fortune della plastica sono maggiori. E se centri mitici per la scultura come Middelheim hanno ripetutamente richiesto i suoi lavori, una città quale Milano, che non solo si vanta d'essere la capitale dell'arte italiana, ma è quella in cui Balderi da sempre vive e opera, ha visto solo eccezionalmente, almeno a livello pubblico, quanto egli fa. Certo le sue prime personali si sono, direi per forza di cose, svolte qui: tra il 1963, data della prima uscita organica, nella Galleria Minima, e il 1969, allorché lo propose una galleria di gran classe come quella mitica dell'Ariete di via Sant'Andrea, quando mi capitò di fare d'accompagnatore all'artista con un testo sul catalogo, dopo che, nello stesso anno, egli era stato presentato nei suoi spazi da Enzo Pagani, uno dei rari galleristi amanti della scultura non solo a parole. Poi più nulla, o quasi, per tutti gli anni Settanta e Ottanta. Rarissime le eccezioni, fino a l'occasione nel 1989, del “Percorso della scultura” in Corso Vittorio Emanuele. Che avrebbe dovuto risvegliare almeno gli specialisti, ma è invece servita ben poco, anche per certa generosa ma improvvida gestione dell'iniziativa. E quando, nei mesi subito successivi, avanzai la candidatura di Balderi per la retrospettiva, alla permanente, sulla “Scultura a Milano 1945-1990” Trovai il più gentile, ma anche il più completo disinteresse, cossicché la sua presenza fu anche in quell'occasione trascurata.
Balderi ha subito l'ennesima disattenzione con distacco filosofico, come è suo costume. E anche ora, per questa mostra, ci sono voluti degli estimatori sicuri, e insistenti, per stanarlo dal suo studio, che oltre che laboratorio è spazio di meditazione, dove Iginio non solo realizza, e concepisce, le sue forme, ma si astrae dalle cose pratiche del mondo (prima di tutto di quel mondo piccolo e artificiosamente agitato che è quello dell'arte), con una qual indolente svagatezza, che è dei saggi. Balderi è infatti tutto, e da sempre, rivolto all'interiorità. Che è interiorità di vita e di pensiero, ma pure interiorità della scultura. Lungo due principali direttrici, o meglio lungo due registri d'una stessa, indivisibile unità: l'affondo nell'essenza di questo linguaggio oggettuale primitivo, se così si può dire (Baudelaire lo definì “da Caraibi”), e la volontà di caricarlo d'una significanza dell'assoluto, o almeno del non irrimediabilmente contingente.
Ed ecco la ricerca, fin dall'inizio, di qualità strutturali e plastiche insieme “primarie” e dense di senso: obiettivo che parrebbe incongruo e illusorio nel contesto della cultura odierna, innervata da tutt'altre intenzionalità e rivolta a mete ben diverse. Tanto che pare logico il tramonto non dico della scultura, ché sarebbe asserzione apocalittica e generica, ma d'un certo tipo di scultura, che è poi quella che Balderi continua a praticare: da artista tuttora radicato nelle ambizioni propositive delle avanguardie storiche. Che infatti egli studia, dialogando con i loro esiti, confrontandovisi, fuori di quel citazionismo nomade (anche se “citazioni” in Balderi non mancano, e da più fonti) che è ovviamente di tutta altra natura e orientamento e certo, non si può non costringerlo, più consono ai riti e ai ritmi dell'oggi.
Col che non si vuol affermare che Balderi non sia uomo del nostro tempo, ma che questo tempo, che inevitabilmente é anche il suo, lo affronta con intenzionalità “forti”, poco in sintonia con la temperie postmoderna, di cui peraltro a modo suo alla fine partecipa, come pure è inevitabile. Ognuno infatti - mi si scusi la banalità lapalissiana- è “figlio del proprio tempo”. Ma il tempo da cui ciascuno è segnato è sia quello che si svolge attorno noi, ogni giorno, sia quello in cui ogni singolo s'è formato che, sempre inevitabilmente, ”data” ciascuno, limitandolo, se si vuole, ma anche caratterizzandolo, dandogli una fisionomia. E ciò si verifica, volere o no, per tutti, c'è tuttavia chi - per indole e progetto di vita - maggiormente preserva le matrici da cui s'è mosso, dando quindi scarsa attenzione al veloce trascorrere delle suggestioni che si succedono, anche in arte. Come, appunto, Balderi.
Per cui non dovrebbe sorprendere che, scrivendo dell'artista per il ricordato milanese “Percorso della scultura” , e proprio a proposito delle opere, per allora, più recenti, mi sia capitato di rifarmi, addirittura, al precedente lontano di Boccioni: per il complesso relazionarsi, entro un avvitamento spiraliforme, di volumi reali e virtuali, in un intreccio intimo di forze contripete e centrifughe, coinvolgente potentemente lo spazio esterno attraverso la proiezione del nucleo plastico delle sue potenziali energie. Col risultato, tra l'altro, di proporre la riconquista d'una monumentalità non monumentale, anche appunto perché non impermeabilmente chiusa in se stessa, che fa intuire, osservavo appunto, un intelligente rimeditazione del grande Boccioni, delle sue “forme uniche della continuità nello spazio”, dal “fondamento architettonico, non soltanto come costruzione di masse, ma in modo che il blocco scultoreo abbia in se gli elementi architettonici dell'ambiente scultoreo in cui vive il soggetto”, secondo la definizione del maestro futurista, che, concludevo, alle odierne ricerche di Balderi, significativamente intitolate alla Città, potrebbe far da didascalia.
Sifatte esperienze, di fatto in augurate sullo scorcio degli anni Settanta, sono riproposte in questa mostra: dalle Spirali 1979 e 1981 alle città, che da esse discendevano per crescita organica, negli anni successivi, all'insegna, sempre, dell'organizzazione conseguente di pieni e vuoti, nel fluire continuo della spirale. E c'è qui, ovviamente, in primo luogo, la riproposizione - e proprio sul piano strutturale che aveva affascinato Boccioni - di un problema primario nella scultura moderna, da Medardo Rosso in avanti: quello della rottura dell'isolamento della statua e dell'interrelazione di spazio interno e spazio esterno: da cercare e risolvere oltre agli aggiustamenti di superficie dati da vibrazioni atmosferiche o da cauti sommovimenti pittorici, nella riconsiderazione, invece, dei termini – oggettuali, materici, di ingombro ambientale - della scultura.
Con un lavoro nella e sulla forma che Balderi spinge peraltro oltre quello “stile del movimento” che Boccioni vuole realizzare “rendendo sistematico e definitivo come sintesi quello che l'impressionismo ha dato come frammentario, accidentale, quindi analitico”, approdando agli esiti cui, in quel vecchio testo, mi riferivo. Iginio infatti cerca una “durata” differentemente orientata da quella di “creazione di una nuova costruzione emotiva” di Boccioni. Aspira, piuttosto, a dar corpo non effimero alla significanza del simbolo.
Non a caso una delle più impegnate, anche nello sviluppo quantitativo, di queste Città del 1985, fa venire alla mente la Torre di Tatlin, e, à rebours, il Progetto di un Monumento del 1898-1900 di Obrist, nei quali lo spessore appunto simbolico manifestamente impregna la forma a spirale, pure fondante in Balderi. Che tuttavia, nelle Città venute in seguito, sino ad oggi, e in gran parte qui esposte per la prima volta, ha ripreso la tensione ad una primordialità che richiama piuttosto Brancusi, modello ideale del fare scultura del nostro artista, prima ancora che di sue specifiche scelte espressive. E ciò, sia pur embrionalmente, sin dall'inizio del suo lavoro, come addirittura può provare una rarissima testimonianza dei finali anni Cinquanta come Giocolieri, che apre questa mostra. In essa, certo, è viva la lezione di Marino, che di Balderi era stato maestro Brera. Al grande scultore rimanda l'uscita, quasi per gemmazione, della figuretta in alto, da quella più grande che le sottostà. In filigrana ci sono certi suoi Miracoli: però non solo come addolciti plasticamente, ma sottoposti ad un processo di riduzione, oltre lo scatto drammatico, oltre l'espressività, che quei capolavori di Marino rendevano scattanti e vivi.
Così stirati in verticale, i Giocolieri preannunciano le Colonne, cui Balderi giunge l'anno dopo attraverso XY, che ne prepara l'elevazione e la sintesi, tuttavia in qualche misura frenata dalla un poco compiaciuta turgida conclusione dalla parte estrema. E sono, queste Colonne, cui Iginio si applica per un triennio, un episodio d'una rilevanza che va ben oltre la storia singola dell'artista, ponendosi tra capisaldi - nell'interagire di ordine e trasgressione, di definizione strutturale e di lievitante materismo, di intrusione nello spazio e di apertura adesso - di quella particolare, e per certi versi eccezionale, congiuntura che si realizza Milano in ambito plastico tra anni Cinquanta e Sessanta, le cui radici sono in Lucio Fontana e in Umberto Milani, d'altronde ancora attivi e quindi presenti anche come stimolo diretto.
Le ragioni della forma e quelle della dinamica essenziale, della struttura e della materia, del volume e dello spazio, e se si vuole anche della tradizione e della modernità - si pensi ad un Somaini, o a Arnaldo e Giò Pomodoro, oppure a un Rambelli - interagiscono vivacemente, più per un simultaneo emergere, e scontrarsi, di pulsioni, esigenze, di aspirazioni che per il definirsi d'una dialettica ordinaria. Sullo sfondo pure, naturalmente, della sfida dell'informale alle presupposte integrità della scultura, e alle sue stesse, e altrettanto preconcette, sue impossibilità. Sono le coordinate entro cui nascono queste Colonne, partecipi, anche nella modellazione di certe parti, del materico palpitare informale e nel contempo indirizzate alla riconquista d'una, sia pur nuova, determinatezza oggettiva. Tuttavia pure personalissimamente protese ad una dimensione arcaica auroralmente originaria, che si evolverà poi, subito dopo la metà del decennio, in forme levigate, esatte, come incontaminate, che hanno lasciato alle spalle il sottile, inquietante corrodersi delle Colonne, delle prime soprattutto.
È il momento di Eptatlon, di Le Cariti, di Atreo, dei Penati, di Eos, de La carpa d'oro, della veramente brancusiana – per le implicazioni di trascendenza - Tavola degli dei, che hanno un che di rarefatto, anche per il candore della materia (nelle versioni originali in fibra di vetro, poi tradotte, con altre valenze, in bronzo), singolarmente coesistente con un esserci a suo modo perentorio, e in ogni caso ben definito, che da sensibilmente la compresenza di passato e di presente, oltre che di flagranza oggettuale e di imprendibilità concettuale. Con sottigliezza mentale e anche con una vena nostalgica, e senza alcun appesantimento erudito, archeoligizzante, Balderi fissa nel corpo della scultura la presenza del mito come realtà viva nella memoria culturale. Lo stesso problema del rapporto, molteplice, tra struttura e spazio, nella dinamica tra apertura e chiusura, già apparso nelle Colonne e poi, s'è visto, primario nelle ricerche successive delle Città trova ora una sedimentazione come raffreddata, funzionale alle intenzionalità evocative e di intensificazione dello spessore significante.
È un percorso che sfocia nelle Sette Variazioni di un tema, che fanno programmaticamente cadere l'accento sui valori formali, nella critica dichiarata, però, a quel geometrismo formalistico, manieristicamente fine a se stesso, angustamente autoriflessivo in cui si sono arenati tanti epigoni, e in sostanza traditori, di Brancusi, o anche Arp. Secondo originali inflessioni minimalistiche, Balderi organizza spericolati equilibri, lavora sui nessi tra solidi dalla superficie piana e curva, poliedri ed ellissoidi, energicamente tesi eppure come immobili in una indefinibile fissità, tra fenomeno ed essenza, realizzando in essi quella risonanza simbolica che da ora è preminente. “Dopo dieci anni di ricerca sulle forme attraverso la scultura” - ha scritto l'artista a proposito delle Variazioni nel 1974, al culmine, ormai, di queste esperienze - “sono arrivato a due forme primarie: una è l'uovo che è una rotazione dell'ellisse e ha per sezione il cerchio, l'altra il prisma la cui sezione è il triangolo. Con questi due elementi, componendoli, propongo sette possibilità di metterli insieme che sono sette sculture, sette sculture diverse anche se composte con gli stessi elementi”. Però con una finalizzazione non grammaticale o sintattica. “ogni scultura è per me”, continua Balderi in quel medesimo testo, ”un simbolo misterioso della vita, un segno e una rappresentazione della esistenza umana sul nostro pianeta”; e “l'uovo è una sfera – corpo celeste – messa in rotazione dentro un ellisse – il movimento interno al suo sole – il suo viaggio” : “non una cosa fissa – statica – ma dinamica: è vita; l'uovo è il simbolo più alto della vita”.
Su tale forma che archetipa tanto elementare quanto densa di connotazioni, Balderi si affatica a lungo, cercando una consustanzialità di contenuto e forma, fino ad una forse troppo voluta, perciò non pienamente risolta nella scultura, intensificazione delle implicazioni simboliche, con insistenti riferimenti cosmogonici e alchemici, come nei qui esposti Omaggi a Zarathustra e a J.W. Dunne del 1977, che avrebbero potuto pericolosamente appesantire i risultati. Ma è di qui che nascono, con scatto nuovo, Spirali e Città, delle quali s'è detto, e che, negli esiti ultimi, rifrequentano, già lo si accennava, la significanza “brancusiana”, con fusti-colonna che, rivisitando ormai antiche soluzioni, offrono un primordiale levarsi, ora concluso in nuclei spirali, oppure anche, ancora, ad uovo (Esonartece II, 1990). Con una certa inedita inquietudine, mi pare di avvertire, nell'affidarsi degli steli e nel loro torcersi, che la ricercata patinatura accentua, come l'accostamento, che l'autore opera, di più elementi in aggregati ove dominano l'estraneità e l'isolamento. Come nelle filiformi figure di Giacometti, però gelate, cristallizzate, addirittura private del fremito, ancorché dolente, della vita.
Luciano Caramel, 1992